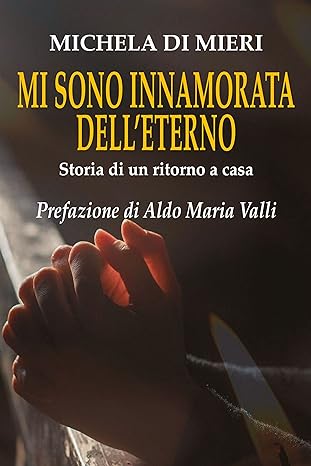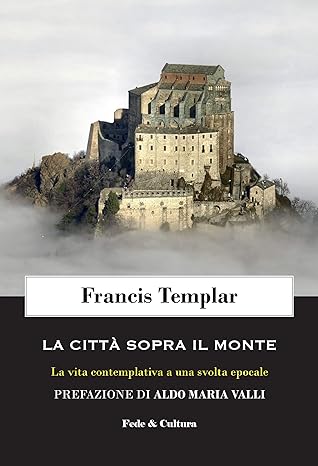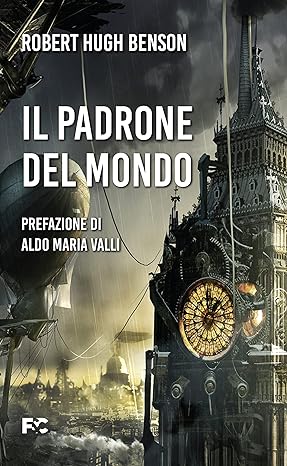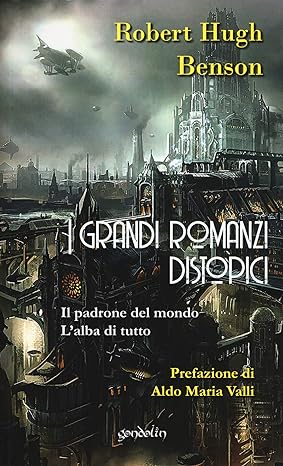Dentro la borsetta della sopravvivenza meglio mettere qualche (buona) idea
di Vincenzo Rizza
Caro Aldo Maria,
come Duc in altum ha già raccontato [qui], il commissario europeo alla gestione delle crisi, Hadja Lahbib, in quello che vorrebbe essere un ironico video istruttivo, ha elencato ciò che dovrebbe contenere una borsa in caso di emergenza: documenti di identità in una custodia impermeabile, una bottiglia d’acqua, una torcia, occhiali da vista, un coltellino svizzero a diciotto funzioni, fiammiferi e accendino, farmaci, cibo in scatola, soldi contanti (ma il contante non doveva sparire?), un caricatore, una power bank, carte da gioco, una piccola radio.
Ringrazio sempre gli ineffabili burocrati europei per la loro solerte operosità nel pensare al mio futuro. Mi permetto, tuttavia, di suggerire ossequiosamente qualche modifica che potrebbe consentire alla commissione europea, prima che il kit diventi obbligatorio per legge con verifiche porta a porta delle forze dell’ordine e multe per chi abbia acquistato un coltellino svizzero con sedici anziché diciotto funzioni (visti i tempi non ci vorrà molto), di perfezionare l’equipaggiamento. I miei suggerimenti hanno un duplice vantaggio: alleggeriscono il peso della borsa e sono validi sia in tempo di crisi che, direi soprattutto, in tempo di pace.
Personalmente, infatti, svuoterei del tutto la borsa: inutile portare pesi, tanto più in caso di calamità e guerre. Cercherei, piuttosto, di riempire il cervello mettendo dentro un pizzico di saggezza, un minimo di equilibrio, un po’ di intelligenza e tanto, tanto buon senso. Tutta merce diventata rara, quasi introvabile alla borsa nera dell’ovvio, tanto in tempo di crisi quanto, purtroppo, in tempo di pace.
Se, infine, dobbiamo leggere qualcosa per passare il tempo, suggerirei di portare in borsa un testo di circa duemila anni fa: vero che all’epoca non c’erano i registratori ma le fonti sembrano attendibili e qualcosa di buono lo si può senz’altro trovare. Se poi la laicità europea impedisce di far riferimento a testi religiosi, anziché trovare conforto in manifesti dell’arcipelago ponziano preferirei portare con me un manifesto scritto a Oxford nel 1947 in risposta agli orrori prodotti da due guerre mondiali e contro la deriva e l’autoritarismo comunista. Anche questo va contestualizzato ma qualche principio vale sempre la pena ricordarlo.
“L’uomo è innanzi tutto un essere dotato del potere di pensare e di agire liberamente e della capacità di distinguere il bene e il male”.
“Il rispetto per la persona umana e per la famiglia è la vera base della società”.
“Lo Stato è soltanto uno strumento della comunità: esso non deve assumere alcun potere che possa venire in conflitto con i diritti fondamentali dei cittadini e con le condizioni indispensabili per una vita responsabile e creativa, e precisamente: la libertà individuale, garantita da un’amministrazione indipendente della legge e della giustizia; la libertà di culto e la libertà di coscienza; la libertà di parola e di stampa; la libertà di associarsi e di non associarsi; la libera scelta dell’occupazione; la possibilità, di una piena e varia educazione, secondo la capacità di ognuno e indipendentemente dalla nascita o dai mezzi; il diritto di proprietà privata e il diritto di iniziativa individuale; la libera scelta del consumatore e la possibilità di godere pienamente dei frutti della produttività del suolo e dell’industria dell’uomo; la sicurezza dai rischi di malattia, disoccupazione, incapacità e vecchiaia; l’eguaglianza di diritti tra uomini e donne”.
“La soppressione della libertà economica conduce inevitabilmente alla scomparsa della libertà politica. Noi ci opponiamo a tale soppressione tanto se è conseguenza della proprietà o del controllo statale quanto se risulta da monopoli, cartelli o trusts privati. Noi ammettiamo la proprietà di Stato solo per le imprese che vanno oltre le possibilità della iniziativa privata o là dove la concorrenza non ha più modo di operare”.
“La guerra può essere abolita, la pace del mondo e la prosperità economica possono essere ristabilite soltanto se tutte le nazioni si attengono alle seguenti condizioni: la partecipazione leale a un’organizzazione mondiale di tutte le nazioni grandi e piccole, retta da principi uniformi di diritto e di equità, con il potere di imporre la stretta osservanza di tutte le obbligazioni internazionali liberamente contratte; il rispetto per il diritto di ogni nazione di godere delle libertà umane essenziali; il rispetto per la lingua, la religione, le leggi e i costumi delle minoranze nazionali; il libero scambio delle idee, delle notizie, delle merci e dei servizi fra le nazioni, e la libertà di movimento all’interno di ogni Paese e fra Paese e Paese, senza gli ostacoli costituiti dalla censura, dalle barriere commerciali protezionistiche e dalle restrizioni sui cambi; lo sviluppo delle aree arretrate del mondo con la collaborazione dei loro abitanti, nel loro vero interesse e nell’interesse del mondo intero”
(Manifesto di Oxford del 1947 – Fondazione Luigi Einaudi).
Principi, questi, troppo spesso dimenticati da un’Unione europea che sembra sempre più lontana dalla visione dei padri fondatori (innanzitutto Robert Schuman, Konrad Adenauer e Alcide De Gasperi, che volevano unire popoli accomunati dalle stesse radici cristiane) e sempre più vicina all’autoritarismo (di matrice socialista) che ha ispirato gli ideatori del Manifesto di Ventotene.