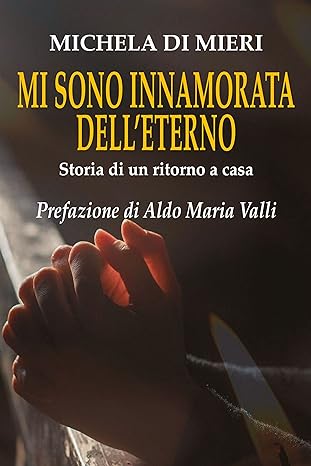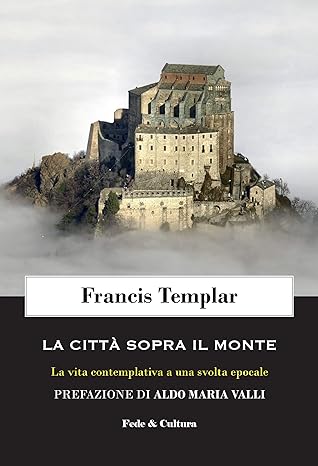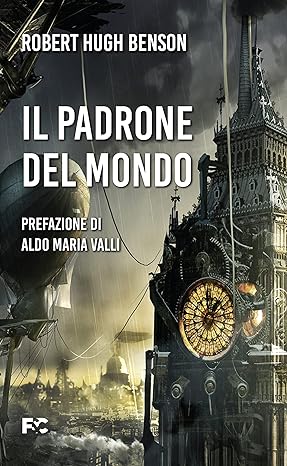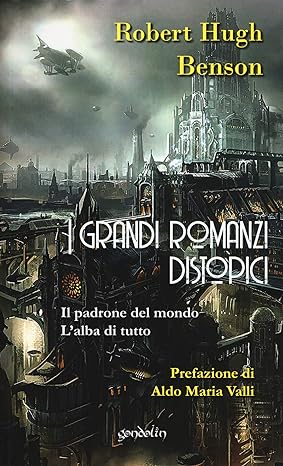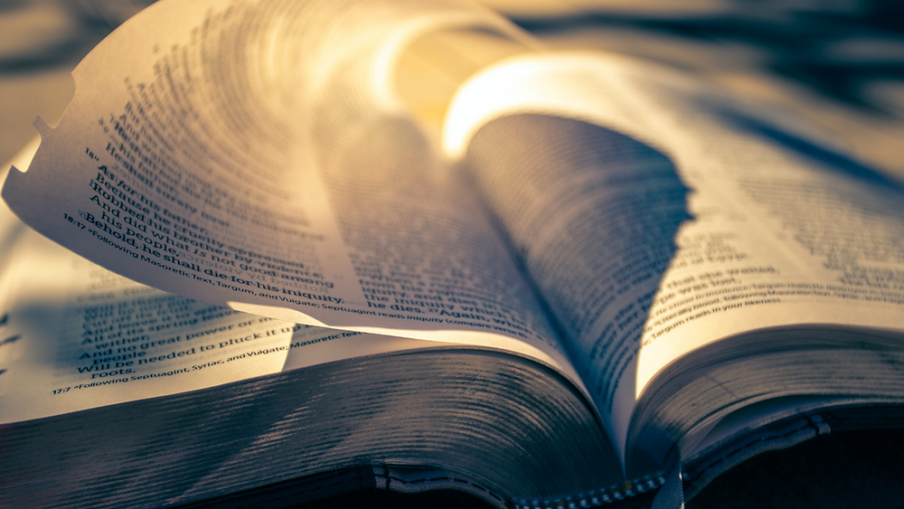
No, la storia della Bibbia non inizia con Lutero. Risposta a un’intervista al professor Melloni
di Investigatore Biblico
Leggendo l’intervista al professor Alberto Melloni pubblicata recentemente (qui), non si può non rimanere colpiti – e con una certa amarezza – da una narrazione che appare tanto suggestiva quanto storicamente fragile.
Affermare che «la storia della Bibbia inizia cinquecento anni fa con Lutero» significa non solo trascurare secoli di vita ecclesiale nutrita dalla Parola di Dio, ma anche svilire il lavoro di innumerevoli santi, padri, monaci, esegeti e traduttori che, ben prima della frattura protestante, avevano posto la Scrittura al centro della vita cristiana.
La Bibbia non inizia con Lutero. Essa si fa carne nella comunità dei discepoli fin dai primi secoli. San Girolamo, nel IV secolo, su incarico di papa Damaso, tradusse l’intero corpus scritturistico dal greco e dall’ebraico al latino, consegnando alla Chiesa la Vulgata, frutto non di una coscienza individuale ribelle, ma di una obbedienza ecclesiale profonda. Ben prima ancora, le versioni della Vetus Latina testimoniavano una Chiesa già attenta a rendere le Scritture accessibili ai fedeli latini. Non si tratta, dunque, di un’opera post-riforma, ma di un cammino antico e condiviso.
Nel Medioevo i monasteri furono laboratori silenziosi della Parola. I salmi erano la linfa della preghiera quotidiana; le letture bibliche scandivano le ore liturgiche. I sermoni di sant’Agostino, san Gregorio Magno, sant’Ambrogio sono colmi di citazioni bibliche, spiegate, meditate, applicate. La Chiesa viveva della Scrittura e la Scrittura viveva nella Chiesa.
Nel XVI secolo, Sante Pagnini, domenicano lucchese, dedicò oltre trent’anni alla traduzione della Bibbia dai testi originali in ebraico e greco, pubblicando nel 1527 la sua Veteris et Novi Testamenti nova translatio. Questa versione, nota per la sua fedeltà letterale ai testi originali, fu consultata anche da Martin Lutero, a testimonianza del continuo impegno della Chiesa cattolica nella traduzione e diffusione delle Sacre Scritture.
Ma l’errore più grossolano dell’intervista è un altro. Melloni afferma che «la libertà del cristiano si manifesta nella conoscenza della Scrittura, nella Bibbia tradotta nelle lingue parlate», come se la traduzione in lingua volgare fosse una novità cinquecentesca.
Anche questa affermazione è storicamente infondata.
È vero, come dice Melloni, che nel 1266, Mario Cignoni tradusse il Vangelo di Giovanni in volgare toscano: il più antico testo evangelico completo noto in lingua volgare italiana. Ma vi sono testimonianze ancora precedenti: si pensi al Salterio di san Romualdo: conservato presso la biblioteca di Camaldoli, è databile tra la fine del IX e l’inizio del X secolo. Questo codice rappresenta un esempio precoce di traduzione dei salmi per scopi liturgici e devozionali. E ancora, nel XII secolo, la Bibbia Istorica di Pietro da Riga, benché in versi latini semplificati, fungeva da strumento di divulgazione narrativa e dottrinale della Scrittura tra il popolo.
La Chiesa, quindi, non solo conosceva la necessità della traduzione, ma la promuoveva là dove era spiritualmente fruttuosa. Sempre sotto guida e discernimento ecclesiale, mai in solitaria pretesa di autosufficienza esegetica.
È quindi con viva preoccupazione che si legge questa frase dell’intervista: «Lutero è l’inventore della coscienza individuale, secondo cui la libertà del cristiano si manifesta nella conoscenza della Scrittura». Qui si dimentica che la libertà cristiana, ben lungi dall’essere una scoperta moderna, è stata cantata da san Paolo con potenza: «Cristo ci ha liberati per la libertà» (Gal 5,1). Ma questa libertà è sempre ecclesiale, mai solitaria; è un’alleanza, non un’autonomia. San Pietro ci ricorda che «nessuna Scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione» (2 Pt 1,20).
La «coscienza individuale» non nasce con un atto di rottura, ma nella faticosa conversione del cuore che si misura con la Verità rivelata. Lutero, pur animato da zelo, non inventò nulla. E se vi fu un merito, fu semmai quello – drammatico – di ricordare alla Chiesa qualcosa che essa già sapeva, e che aveva rischiato di trascurare sotto il peso di una pastorale appesantita.
Ma non si dimentichi: la Scrittura, per il cattolico, non è solo testo, è lettura viva nella Tradizione e nel Magistero. Non è affidata all’arbitrio del singolo, ma alla comunione dei credenti.
Il Medioevo cristiano ha conosciuto voci luminose: san Bernardo di Chiaravalle insegnava che «le Scritture sono la nostra salvezza, il nutrimento dell’anima, il conforto del cuore», mentre Ugo di San Vittore dichiarava: «Tutta la divina Scrittura è un solo libro, e questo unico libro è Cristo». E san Bonaventura esortava: «La Sacra Scrittura è la radice della teologia: chi la trascura, costruisce sulla sabbia».
Ridurre tutto a una svolta cinquecentesca significa recidere le radici profonde che nutrono ancora oggi il nostro rapporto con la Bibbia. Per dirla tutta: non stavamo di certo aspettando Lutero. È come dire che il sole è nato il giorno in cui qualcuno ha aperto le finestre: dimenticando che da sempre esso illumina, anche quando ci si ostina a vivere nell’ombra.
Nel solco della tradizione viva della Chiesa, continuiamo ad ascoltare, meditare, annunciare la Parola, consapevoli che essa non è proprietà di nessuno, ma dono per tutti.
investigatorebiblico.wordpress.com