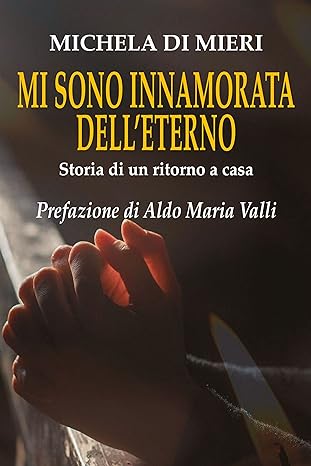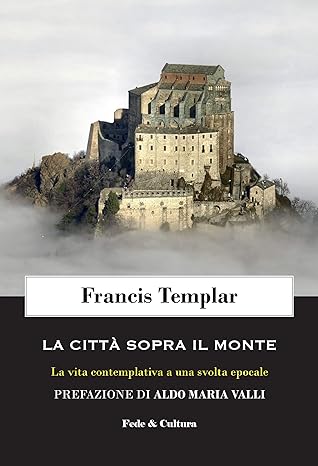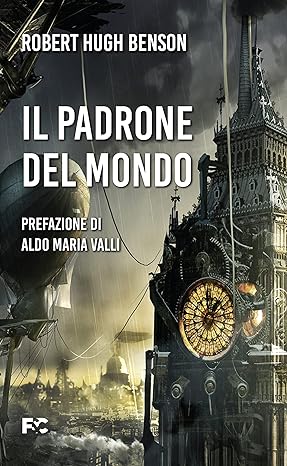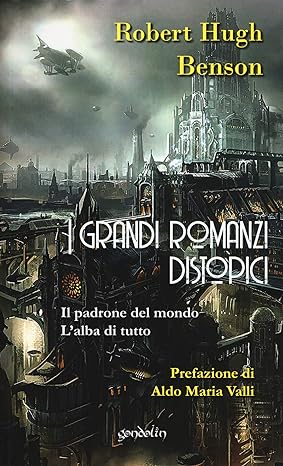C’era una volta il giubileo. E c’è ancora (anche se non sembra). Origini e storia di un anno di grazia
Paolo Gulisano è medico di professione e scrittore per passione. Al suo attivo ha numerosi libri dedicati a temi letterari e storici. Ricordiamo il saggio sulla persecuzione dei cattolici in Messico e le biografie di santi come J.H. Newman, Colombano, Malachia, Patrizio, Giuseppe Moscati.
Ed ora ha appena dato alle stampe un volume sulla storia degli anni santi, dal 1300 a oggi.
Perché un libro sui giubilei?
Il giubileo è una delle più straordinarie realtà prodotte dalla Chiesa cattolica nella sua storia bimillenaria. Non fu il risultato di un progetto pastorale – per usare un termine contemporaneo – ma l’esito di una serie di fattori, provenienti in buona parte dalla Tradizione popolare e da suggestioni della spiritualità medievale, che andarono a innestarsi sul patrimonio religioso ereditato dall’ebraismo. Il primo giubileo della storia fu indetto nel 1300 da papa Bonifacio VIII, al secolo Benedetto Caetani. Ne fu occasione l’ondata di spiritualità, desiderio di perdono e ricerca di fratellanza che si stava diffondendo in tutta la cristianità in contrapposizione agli odi e alle violenze dominanti in quell’epoca.
Il giubileo nasce quindi nel clima particolare del Medioevo. Ben lungi dall’essere stato il tempo più “buio” dell’umanità, come sostenevano gli ideologi illuministi, il Medioevo fu un’epoca di grande vivacità culturale, di arti, liberi mestieri, viaggi, scoperte, avventure, e di una religiosità intensissima.
Che significato aveva il giubileo?
Il giubileo nasce al culmine del Medioevo, mentre diverse civiltà sono all’apogeo, prima che nel giro di un secolo andassero a decadere, in particolare per colpa della più grande pandemia che abbia mai afflitto l’umanità, la Morte Nera del 1348. Nasce all’indomani della fine delle crociate. L’ultima aveva avuto luogo nel 1270, ed era finita con un insuccesso. La Terra Santa era irrimediabilmente perduta. Preso atto realisticamente della sconfitta, la Chiesa cercò di promuovere altri tipi di pellegrinaggio. Il viaggio non era più indirizzato verso l’Oriente, ma lo scopo della ricerca era sempre lo stesso: lasciarsi alle spalle le violenze e le contraddizioni della propria terra per giungere al regno della giustizia e tornare a casa portando in sé il miracolo di un cambiamento.
Nel libro si racconta di come l’idea di pellegrinaggio andò a coniugarsi con quella di penitenza, di riparazione delle conseguenze del peccato.
Infatti. Le premesse all’idea di giubileo vengono poste da san Francesco d’Assisi, che aveva ricevuto da Gesù il mandato di riparare la sua Chiesa, ovvero di restaurarne la sua primitiva bellezza. Riparare, sottolineo: non riformare. L’unica vera riforma della Chiesa è tornare pienamente a Cristo. Il Perdono di Assisi, che prevedeva che chiunque avesse visitato la Porziuncola dal mezzogiorno del 1º agosto alla mezzanotte del 2 agosto avrebbe ricevuto l’indulgenza plenaria, fu un ulteriore passo di avvicinamento all’idea di giubileo.
Il libro ripercorre oltre settecento anni di storia. Attraverso le vicende degli anni santi, e dei papi che ne furono i protagonisti, sei riuscito a realizzare una vera e propria sintesi di storia della Chiesa.
In effetti, ripercorrendo gli anni santi passiamo dal Medioevo allo Scisma d’Occidente, con le divisioni tra seguaci dei papi e dei vari antipapi che si susseguirono. Poi ecco il tempo delle spaccature dovute agli scismi protestanti, di Lutero, Calvino e Enrico VIII. Poi la grande risposta che venne dalla Controriforma, con il Concilio di Trento che prese il via proprio in occasione di un anno santo. E poi ancora il Settecento, l’Illuminismo, la Massoneria, la Rivoluzione Francese, l’odio implacabile scatenato contro la Chiesa. Il libro mostra che la storia della Chiesa non è solo storia di grandi successi spirituali e civili, ma è anche una storia di sconfitte, amarezze, delusioni, sofferenze. La Chiesa è fin dall’inizio Chiesa di martiri, di perseguitati. I primi passi della Chiesa furono dolorosi e allo stesso tempo gloriosi. Nel corso dell’Ottocento addirittura la celebrazione dei giubilei del 1800, 1850 e in parte del 1875 venne impedita dall’odio contro Cristo e la sua Chiesa.
Nel libro sottolinei il fatto che talvolta il giubileo si svolse senza papa. Un po’ come adesso…
Esatto. Il giubileo del 1350 si caratterizzò per l’assenza del papa, poiché Clemente VI, viste le circostanze politiche del momento, restò nella sua sede ad Avignone. Come i suoi immediati predecessori, Clemente VI fu subalterno alla Francia e fece mostra di questa preferenza restando sordo alle richieste di rientro per lo meno in occasione dell’anno santo.
Oggi a causa della malattia e della lunga e un po’ anomala convalescenza post ospedaliera di papa Bergoglio il giubileo si sta svolgendo senza la presenza del pontefice. Forse anche per questo aspetto si avverte diffusamente scarso interesse ed entusiasmo nei confronti dell’anno santo in corso. Sembra evidente la differenza con giubilei del passato, come il grande giubileo del 2000 che segnò l’ingresso nel terzo millennio…
Certamente. Ma c’è un altro aspetto da sottolineare: in tutta la storia dei giubilei gli anni santi sono sempre stati momenti di conversione, pentimento e di richiesta di perdono dei peccati. Oggi ci troviamo di fronte a un’eclissi del senso del peccato. Se Dio perdona todos, todos, a prescindere, che bisogno c’è di un momento forte in cui rivedere la propria vita, confessare i propri peccati e chiederne la remissione? È come se si riscrivesse il Vangelo dell’adultera, quello del “chi è senza peccato scagli la prima pietra”, ma senza Gesù che si congeda dall’adultera dicendole con dolcezza ma anche con fermezza “va’ e non peccare più”. Questa richiesta che Cristo fa da duemila anni ai peccatori e alle peccatrici oggi non viene più riecheggiata dalla neo-chiesa.
Nonostante tutto, dal libro traspare una lettura positiva della storia della Chiesa e un sentimento di speranza.
In duemila anni di storia la Chiesa è sopravvissuta agli attacchi esterni e alle debolezze interne attraverso i santi, la roccia solida alla quale la cristianità si è sempre aggrappata per non franare. I santi hanno mostrato che seguire Cristo vuol dire ottenere la salvezza ma anche una gioia insolita nella vita terrena. In latino, la lingua ufficiale della Chiesa, la parola giubilo, e il verbo giubilare, sono strettamente connessi con il concetto di gioia. Il cristianesimo non è semplicemente l’osservanza di un insieme di regole e di leggi, ma l’annuncio di un avvenimento di gioia, conseguenza della salvezza portata a ogni persona da Gesù Cristo. Nel Nuovo Testamento Gesù si presenta come colui che porta a compimento l’antico giubileo, essendo venuto a “predicare l’anno di grazia del Signore”, come dice Isaia. La Chiesa ha una missione salvifica rispetto all’intera famiglia, e il giubileo, nonostante tutto, deve aiutarci a viverla e a testimoniarla.
__________________________________