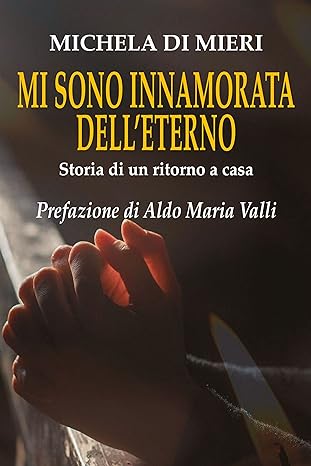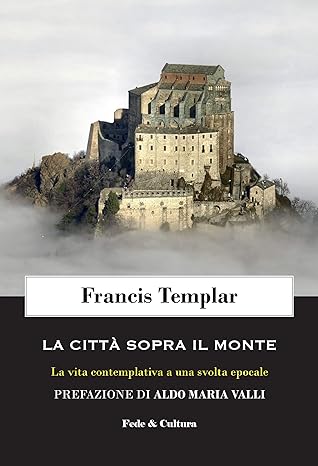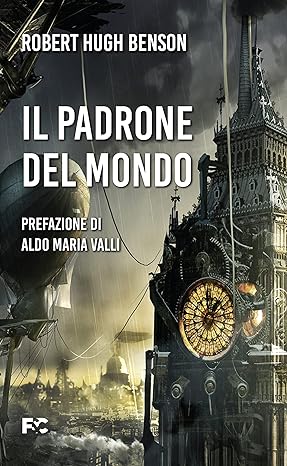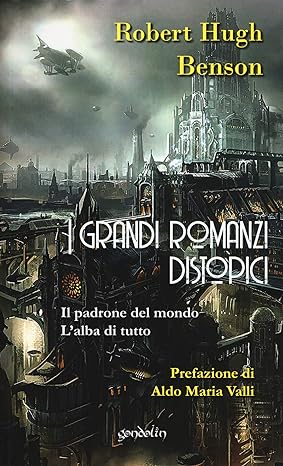Dodici cose da sapere sul Sabato Santo e la Veglia Pasquale
Ogni volta che professiamo il Credo diciamo che Gesù “discese agli inferi”. Il Sabato Santo è il giorno in cui si commemora questo evento. Cosa è successo in questo giorno e come lo celebriamo?
Ecco dodici cose che un cattolico dovrebbe sapere su questa giornata.
Cosa accadde il primo Sabato Santo?
Qui sulla Terra i discepoli di Gesù piansero la sua morte e, poiché era giorno di sabato, si riposarono.
Luca nota che le donne tornarono a casa: “E tornarono indietro e prepararono aromi e mirra. E il sabato osservarono il riposo, secondo il precetto” (Luca 23:56).
Presso la tomba, le guardie che erano lì vegliavano per assicurarsi che i discepoli non rubassero il corpo di Gesù.
Nel frattempo . . .
Cosa accadde a Gesù mentre era morto?
Secondo il Catechismo della Chiesa cattolica:
633 La Scrittura chiama inferno, sheol o ade, la dimora dei morti in cui Cristo è disceso dopo la sua morte (cfr. Fil 2,10; At 2,24; Ap 1,18; Ef 4,9), perché coloro che vi si trovavano erano privati della visione di Dio (cfr. Sal 6,6; 88,11-13).
Tale era, infatti, la condizione di tutti i defunti, empi e giusti, in attesa del Redentore (cfr. Sal 89,49; 1 Sam 28,19; Ez 32,17-32), il che non significa che la loro sorte sia identica, come insegna Gesù nella parabola del povero Lazzaro accolto «nel seno di Abramo» (cfr. Lc 16,22-26).
«Sono proprio queste anime sante, che attendevano il loro Liberatore nel seno di Abramo, che Gesù Cristo ha liberato discendendo agli inferi» (Catechismo Romano, 1, 6, 3).
Gesù non è disceso agli inferi per liberare i dannati (cfr. Concilio Romano, 745: DS, 587) né per distruggere l’inferno della dannazione (cfr. Benedetto XII, Libelo cum dudum: DS, 1011; Clemente VI, c. Super quibusdam: ibid., 1077), ma per liberare i giusti che lo avevano preceduto (cfr. Concilio di Toledo IV, 625: DS, 485; cfr. anche Mt 27, 52-53).
634 «Anche ai morti è stata annunziata la buona novella…» (1 Pt 4,6). La discesa agli inferi è il pieno compimento dell’annuncio evangelico della salvezza.
È la fase finale della missione messianica di Gesù, una fase condensata nel tempo ma immensamente ampia nel suo significato reale di estensione dell’opera redentrice a tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi, perché tutti coloro che sono salvati diventano partecipi della Redenzione.
Come commemoriamo questa giornata?
Secondo il documento principale che regola le celebrazioni legate alla Pasqua, Paschale solemnitatis:
Durante il Sabato Santo la Chiesa rimane presso la tomba del Signore, meditando sulla sua passione e morte, sulla sua discesa agli inferi e attendendo la sua risurrezione attraverso la preghiera e il digiuno. Si raccomanda vivamente la celebrazione dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi con la partecipazione del popolo (cfr. n. 40). Quando ciò non fosse possibile, preparate una celebrazione della Parola o un pio esercizio corrispondente al mistero di questo giorno.
L’immagine di Cristo crocifisso, o nel sepolcro, o che discende agli inferi, può essere esposta nella chiesa alla venerazione dei fedeli, poiché illustrano il mistero del Sabato Santo, come pure l’immagine della Santissima Vergine Addolorata dei fedeli.
Anche in questo giorno è consigliato il digiuno, ma non obbligatorio.
I sacramenti vengono celebrati il Sabato Santo?
Per la maggior parte, no. Paschalis solemnitatis spiega:
Oggi la Chiesa si astiene assolutamente dal sacrificio della Messa. La Santa Comunione può essere data solo come viatico. Non è consentito celebrare il matrimonio né amministrare altri sacramenti, eccetto la Penitenza e l’Unzione degli Infermi.
Il divieto di celebrare la Messa riguarda la parte del giorno che precede la Messa della Veglia Pasquale, che è già considerata domenica.
È consentito anche il battesimo in caso di pericolo di morte.
Che cos’è la Veglia Pasquale?
La Veglia pasquale è la commemorazione liturgica della festa, celebrata la notte precedente la festa (domenica di Pasqua).
Il termine deriva dal latino vigilia, che significa “veglia”, e veniva utilizzato perché i fedeli rimanevano svegli per pregare e compiere esercizi devozionali in previsione della festa.
La Veglia Pasquale è la veglia in cui si celebra la notte prima di Pasqua.
Secondo Paschale solemnitatis:
Fin dalle origini, la Chiesa celebra la Pasqua annuale, solennità delle solennità, con una solenne veglia notturna. La risurrezione di Cristo è proprio il fondamento della nostra fede e della nostra speranza, e attraverso il Battesimo e la Cresima siamo innestati nel mistero pasquale di Cristo, moriamo con Lui, siamo sepolti con Lui e risorgiamo con Lui, per regnare con Lui per sempre.
Questa Veglia è anche un’attesa della seconda venuta del Signore.
Quando verrà celebrata la Veglia Pasquale?
Paschale solemnitatis spiega:
«Tutta la celebrazione della Veglia pasquale si svolge di notte; non deve iniziare prima del tramonto, ma deve concludersi prima dell’alba della domenica».
Questa regola deve essere intesa nel senso più stretto. Sono riprovevoli gli abusi e le pratiche che si sono insinuati in molti luoghi, in violazione di questa norma, per cui la Veglia pasquale viene celebrata nell’ora in cui di solito si celebrano le messe domenicali mattutine.
Le motivazioni addotte da alcuni per anticipare la Veglia pasquale, come la mancanza di ordine pubblico, non vengono proposte in relazione alla Vigilia di Natale o ad altri raduni di diversa natura.
Cosa succede durante la Veglia Pasquale?
Secondo Paschale solemnitatis:
L’ordine della Veglia pasquale è organizzato in modo che dopo il servizio della luce e la proclamazione della Pasqua (che è la prima parte della Veglia) la Santa Chiesa riflette sulle opere meravigliose che il Signore Dio ha compiuto per il suo popolo fin dai tempi più antichi (seconda parte o Liturgia della Parola).
Insieme ai nuovi membri rinati nel Battesimo (terza parte) è chiamata alla mensa preparata dal Signore per la sua Chiesa – commemorazione della sua morte e risurrezione – finché Egli ritorni (parte quarta).
Cosa succede durante il rito del lucernario?
Secondo Paschale solemnitatis:
La prima parte consta di una serie di azioni e gesti simbolici, che devono essere compiuti con tale dignità ed espressività, che il loro significato proprio, suggerito dalle ammonizioni e dalle preghiere, possa essere veramente percepito dai fedeli. In un luogo adatto e all’esterno della chiesa, verrà preparato quanto prima il falò destinato alla benedizione del nuovo fuoco, la cui luce dovrà essere tale da dissipare l’oscurità e illuminare la notte.
Preparate il cero pasquale, che, per l’autenticità del segno, deve essere di cera, nuovo ogni anno, unico, relativamente grande, mai fittizio, affinché possa evocare realmente che Cristo è la luce del mondo. La benedizione del cero si farà con i segni e le parole proposti dal Messale o con altri approvati dalla Conferenza episcopale (88).
La processione con cui il popolo entra in chiesa è illuminata solo dalla fiamma del cero pasquale. Come i figli d’Israele erano guidati durante la notte da una colonna di fuoco, così i cristiani seguono Cristo risorto. Nulla impedisce che le risposte «Rendiamo grazie a Dio» siano accompagnate da qualche acclamazione rivolta a Cristo.
La fiamma del cero pasquale passerà gradualmente alle candele tenute in mano dai fedeli, mentre le lampade elettriche rimarranno spente.
Cosa succede durante la Proclamazione della Pasqua?
Secondo Paschale solemnitatis:
Il diacono proclama il Preannuncio pasquale, magnifico poema lirico che presenta il Mistero pasquale all’interno dell’intera economia della salvezza. In caso di necessità, o per mancanza del diacono o impossibilità del sacerdote celebrante, la celebrazione può essere celebrata da un cantore. Le Conferenze episcopali potranno opportunamente adattare la presente proclamazione includendo alcune acclamazioni da parte dell’assemblea.
Cosa succede durante le letture della Scrittura?
Secondo Paschale solemnitatis:
Le letture della Sacra Scrittura costituiscono la seconda parte della Veglia. Essi descrivono momenti culminanti della storia della salvezza, la cui meditazione pacifica dei fedeli è facilitata dal canto del salmo responsoriale, dal silenzio e dalla preghiera del sacerdote celebrante.
La struttura restaurata della Veglia presenta sette letture dell’Antico Testamento tratte dai libri della Legge e dei Profeti, già frequentemente utilizzate nelle antiche tradizioni liturgiche sia d’Oriente che d’Occidente, e due del Nuovo Testamento, vale a dire la lettura dell’Apostolo e il Vangelo. In questo modo la Chiesa, «cominciando da Mosè e continuando con i profeti», interpreta il mistero pasquale di Cristo. Pertanto, per quanto possibile, si leggano tutte le letture indicate, in modo da conservare intatta la natura propria della Veglia pasquale, che esige una certa durata.
Se però le circostanze pastorali consigliano di ridurre ulteriormente il numero delle letture, si leggano almeno tre letture dell’Antico Testamento, in modo che siano rappresentati la Legge e i Profeti; Non si può mai tralasciare di leggere il capitolo 14 dell’Esodo, con il suo cantico.
Dopo la lettura dell’Antico Testamento, si canta l’inno Gloria a Dio, si suonano le campane secondo le usanze di ogni luogo, si dice la preghiera colletta e poi si passa alle letture del Nuovo Testamento. Si legge l’esortazione dell’Apostolo sul Battesimo inteso come inserimento nel mistero pasquale di Cristo.
Poi tutti si alzano in piedi e il sacerdote intona tre volte “Alleluia”, alzando gradualmente la voce, e l’assemblea lo ripete. Se necessario, il salmista o il cantore intona l’Alleluia, che il popolo continua inserendo l’acclamazione tra i versetti del Salmo 117, così spesso citato dagli apostoli nella loro predicazione pasquale. Segue l’annuncio della Risurrezione del Signore con la lettura del Vangelo, culmine di tutta la liturgia della Parola.
Terminata la proclamazione del Vangelo, non si deve omettere l’omelia, anche se breve.
Cosa accade durante la liturgia battesimale?
Secondo Paschale solemnitatis:
La liturgia battesimale è la terza parte della Veglia. La Pasqua di Cristo e nostra viene ora celebrata nel sacramento. Ciò si manifesta in modo più pieno in quelle Chiese che possiedono il fonte battesimale, e ancor più dove avviene l’iniziazione cristiana degli adulti, o almeno il battesimo dei bambini. Anche se nelle chiese parrocchiali non si celebrano battesimi, viene comunque eseguita la benedizione dell’acqua battesimale. Se questa benedizione non viene fatta al fonte battesimale ma nel presbiterio, l’acqua battesimale dovrà poi essere travasata nel battistero, dove verrà conservata per tutto il tempo pasquale. Laddove non si tengano battesimi e non si debba benedire l’acqua battesimale, la benedizione dell’acqua per l’aspersione dell’assemblea verrà fatta in ricordo del battesimo.
Ha poi luogo la rinnovazione delle promesse battesimali, introdotta dalla monizione del sacerdote celebrante. I fedeli, in piedi con le candele accese in mano, rispondono alle domande. Poi avviene l’aspersione: in questo modo i gesti e le parole che li accompagnano ricordano ai fedeli il battesimo ricevuto un giorno. Il sacerdote celebrante esegue l’aspersione, percorrendo tutta la navata della chiesa, mentre l’assemblea canta l’antifona Vidi aquam o un altro canto battesimale.
Cosa accade durante la liturgia eucaristica?
Secondo Paschale solemnitatis:
La celebrazione dell’Eucaristia è la quarta parte della Veglia e ne costituisce il culmine, perché è il sacramento pasquale per eccellenza, memoriale del sacrificio della Croce, presenza del Cristo Risorto, compimento dell’iniziazione cristiana e anticipazione della Pasqua eterna.
Si deve porre grande attenzione affinché la liturgia eucaristica non venga celebrata in fretta; È molto opportuno che tutti i riti e le parole che li accompagnano raggiungano la loro piena potenza espressiva: la preghiera universale, alla quale i neofiti partecipano per la prima volta come fedeli, esercitando il loro sacerdozio regale; la processione delle offerte, alla quale è consigliabile che i neofiti, se ve ne sono, partecipino; la prima, la seconda e la terza preghiera eucaristica, se possibile cantate, con i propri embolismi; Comunione eucaristica, che è il momento della piena partecipazione al mistero celebrato. Durante la Comunione è opportuno cantare il Salmo 117, con l’antifona “Alleluia, alleluia, alleluia“, oppure un altro inno che rappresenti la gioia della Pasqua.
È molto opportuno che la pienezza del segno eucaristico sia raggiunta nella comunione della Veglia pasquale, cioè che il sacramento sia amministrato sotto le specie del pane e del vino. Gli Ordinari del luogo giudicheranno l’opportunità di tale concessione e le sue modalità.